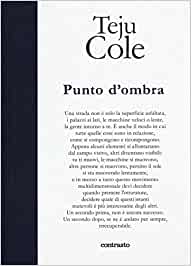
Exploring the world is one the best ways of exploring the mind, and walking travels both terrains.”
― Rebecca Solnit, Wanderlust: A History of Walking
La primissima volta che ho parlato con Teju Cole non sapevo che lo avrei tradotto.
Eravamo in India, a un festival letterario al primo anno di vita a cui eravamo invitati. Lui aveva pubblicato da poco Open City, io avevo tradotto due autori locali. Il festival era talmente nuovo che non c’era pubblico. Per il nostro gruppetto quei tre giorni si erano trasformati in una specie di gita delle medie: chiacchierate interminabili, cene piccanti, lunghe passeggiate sotto un sole implacabile, alcolici devastanti. Ogni tanto qualche reading, a dir poco intimo.
Teju Cole mi era parso immediatamente familiare. Le antenne mi dicevano che le nostre sensibilità potevano incontrarsi.
Sono parecchie le cose che ci accomunano: il piacere di viaggiare e camminare, di guardare e fotografare. La consuetudine a essere altrove, a fare casa con facilità.
Ovviamente nelle nostre conversazioni era spuntato subito Sebald, ma anche Marco Polo e la Schwarzenbach, e poi avevamo parlato soprattutto di città, di cieli, di odori, di facce. Di luce e silenzio e rumori e di come plasmano il nostro passaggio in un determinato luogo. E poi di arte, immagini, fotografia, instagram, social media. Coetzee, Bishop, Siri Hustved, che gli è affine e traduco da tempo. Tante cose. Non avevamo parlato di politica, nelle prime conversazioni. Meglio farla, dice lui giustamente – e il contenuto della sua scrittura è intensamente politico.
Non sapevo che avrei camminato e osservato e chiacchierato con Teju tante volte in questi anni, e quasi sempre in Italia.
Abbiamo vagato per la Biennale di Venezia, sotto il dito di Cattelan a Milano, e di recente in una Roma surreale fino all’alba, parlando della camminata di Mastroianni di cui aveva appena scritto e seguendo i passi svelti di una sua amica americana che ci faceva da cicerone con l’entusiasmo che forse può avere solo chi non è fiaccato dalla vita quotidiana nella città eterna.
Una delle tante frasi che mi tornano ancora in mente da Città aperta, tradotto ormai parecchi anni fa, è “avevo imparato l’arte di ascoltare e l’abilità di costruire una storia partendo dalle omissioni.”
Quando Teju e Contrasto mi hanno proposto di tradurre le immagini parlanti di Punto d’Ombra ho deciso, alla prima stesura, di non guardare le foto. Volevo che le parole camminassero da sole, senza le stampelle di colore o forma.
Ho omesso le foto. Ho ascoltato il ritmo dei passi, esercizio che mi aveva aiutato sempre in Città Aperta. Ho cercato di immaginare il dove. Poi, quando ho riavvicinato i tasselli foto/immagini, e ho riletto, riscritto, riguardato, e riletto ancora con la ottima editor, mi sono placata.
Le foto illuminavano le parole e viceversa. Come quando, sul set, si punta un pannello bianco sul soggetto per dargli luce. Nel linguaggio cinematografico, quel pannello si chiama guarda caso riflesso, e serve ad ammorbidire le ombre o i contrasti fra luci e ombre.
Sono quasi certa che se non avessi la stessa passione di Teju Cole per gli aeroporti, le cartine geografiche, i mappamondi, e soprattutto per l’atto di camminare guardando – in silenzio, con la musica nelle orecchie e il naso per aria – non sarei riuscita a tradurre le sue parole in una voce che non posso, io, definire bella, adeguata, corretta, ma che perlomeno mi rende felice. Anche perché non capita spesso di poter passeggiare per ore con un bravo scrittore, e di vedere con i suoi occhi quello che poi probabilmente finirà in un prossimo libro. Omissioni comprese.
La prossima volta che qualcuno mi chiederà quali sono gli strumenti fondamentali del traduttore, di sicuro mi ricorderò di aggiungere all’elenco infinito “ascoltare sempre, camminare piano e guardare bene”.